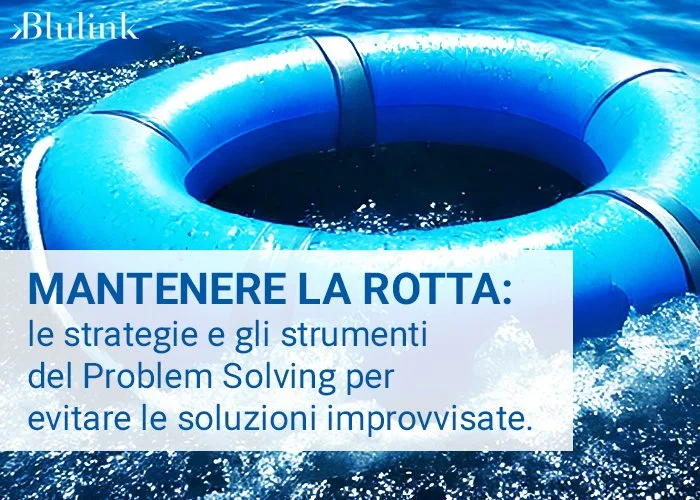Spostandoci poi sul Problem Solving, e partendo sempre dall’analisi etimologica, grazie alla quale scopriamo una somiglianza tra le parole ‘problema’ e ‘progetto’, proviamo a stimolare in Federico e Mattia le loro considerazioni a riguardo.
Mattia, grazie alle informazioni trovate ed elaborate, ci dice che «l’etimologia delle parole “problema” e “progetto” ci offre un’interessante connessione. Entrambe derivano dal greco antico e la loro origine comune può aiutarci a comprendere meglio il concetto di Problem Solving e come esso sia collegato al processo di progettazione. La parola “problema”, dal greco “próblēma” che significa “qualcosa posto davanti” o “impedimento”, indica una situazione o una questione che richiede una soluzione o una risposta. Immaginiamo di dover attraversare un fiume, ma c’è un grande masso nel mezzo. Il masso è il nostro “problema” da risolvere: come superarlo? Come raggiungere l’altra sponda?
La parola “progetto” ha una radice simile. Deriva dal greco “pro-ienai”, che significa “andare avanti” o “avanzare”. Un progetto è un piano o un insieme di azioni organizzate per raggiungere un obiettivo specifico.
Tornando all’esempio del fiume, il “progetto” potrebbe essere la costruzione di un ponte per superare il masso, cosa che richiede pianificazione, risorse e azioni coordinate.
Il Problem Solving quindi è il processo di risoluzione di un problema. Coinvolge l’analisi, la pianificazione e l’attuazione di soluzioni, ovvero una pro-azione. Quando affrontiamo un problema, dobbiamo progettare una strategia per superarlo. Questo è il collegamento tra le due parole: il Problem Solving rappresenta la costruzione del ponte tra il problema e la soluzione, utilizzando il processo di progettazione per guidarci.»
«I due termini, progetto e problema», per Federico, «riportano al concetto di cambiamento e opportunità in una prospettiva volta verso il futuro. Questo collegamento viene anche evidenziato da Juran nella definizione della parola ‘progetto’, descrivendola come un problema destinato a essere risolto (A project is a problem scheduled for solution). Tale concezione sottolinea una correlazione molto stretta, quasi intrinseca, tra le due parole: risolvere un problema, infatti, è spesso il punto di partenza da cui avviare un progetto, cioè trasformare una situazione di insoddisfazione in un miglioramento. La trasformazione da problema a progetto è quindi il mezzo che ci permette di raggiungere nuove opportunità ed evoluzioni.
Le due parole sono anche accomunate dall’iter necessario per risolvere un problema e realizzare un progetto, che è molto simile. Infatti, in entrambi i casi, sono richieste abilità di problem solving, pianificazione e adattabilità per procedere al meglio e trovare le soluzioni più adeguate al contesto in cui ci troviamo.»
Poiché l’iter di soluzione di un problema deve sempre partire dall’ammissione di avere un problema, e dalla sua descrizione condivisa, proviamo a capire insieme ai ragazzi quali sono per loro le fasi più importanti dell’impostazione iniziale della soluzione di un problema, da cui dipende il successo di ciascuno dei passi successivi, e che ruolo possono avere le parole e il linguaggio.
«I passaggi fondamentali per impostare la risoluzione di un problema», afferma Federico, «partono dal quantificare l’impatto del problema nella circostanza in cui ci troviamo (il costo finanziario, l’effetto sulla produttività, l’effetto sulla soddisfazione del cliente, ecc.). Successivamente, è fondamentale fornire una descrizione chiara e precisa del problema, includendo dove e quando si verifica, chi o cosa ne è influenzato, e qualsiasi altro dettaglio rilevante. Dopo aver definito il problema, il passo ulteriore è identificare la causa alla radice, che può richiedere un’analisi approfondita e l’uso di strumenti come il diagramma di Ishikawa o l’analisi delle 5 W (Who, What, When, Where, Why) per comprendere il motivo per cui il problema si è manifestato. In tutte le fasi di risoluzione di un problema, le parole e il linguaggio giocano un ruolo cruciale: un linguaggio chiaro e preciso può aiutare a definire il problema in modo efficace, comunicare le proprie idee agli altri, formulare ipotesi e presentare soluzioni. Infine, un buon uso del linguaggio può facilitare la collaborazione e la condivisione di idee, che sono la chiave per la risoluzione dei problemi.»
Per Mattia, in base a quanto recepito dai suoi studi, «le fasi chiave per impostare con successo la soluzione di un problema sono l’identificazione del problema, l’analisi approfondita e la definizione degli obiettivi. Il primo step è come fare una mappa del tesoro: devi sapere esattamente qual è il problema, lo metti a fuoco e, se necessario, condividi con le persone con cui lavori. Nella fase successiva si scava più a fondo per capire la causa del problema, e in tal caso il sistema delle 5 W è molto usato e utile. La definizione degli obiettivi è come tracciare la rotta su una mappa. Dove vuoi arrivare? Che cosa vuoi ottenere risolvendo questo problema? Impostare obiettivi chiari aiuta a mantenere la direzione. Di conseguenza credo che il linguaggio e le parole sono come il filo conduttore che tiene insieme tutte queste fasi. Usare un linguaggio chiaro e condiviso aiuta a comunicare il problema in modo comprensibile a tutti i membri del team. Le parole possono anche essere strumenti potenti per ispirare e motivare le persone durante il processo di risoluzione del problema, aiutandole a restare focalizzate e impegnate nel raggiungimento degli obiettivi prefissati. Inoltre, un buon uso del linguaggio può facilitare la collaborazione e lo scambio di idee tra i membri del team, portando a soluzioni più innovative e efficaci.»