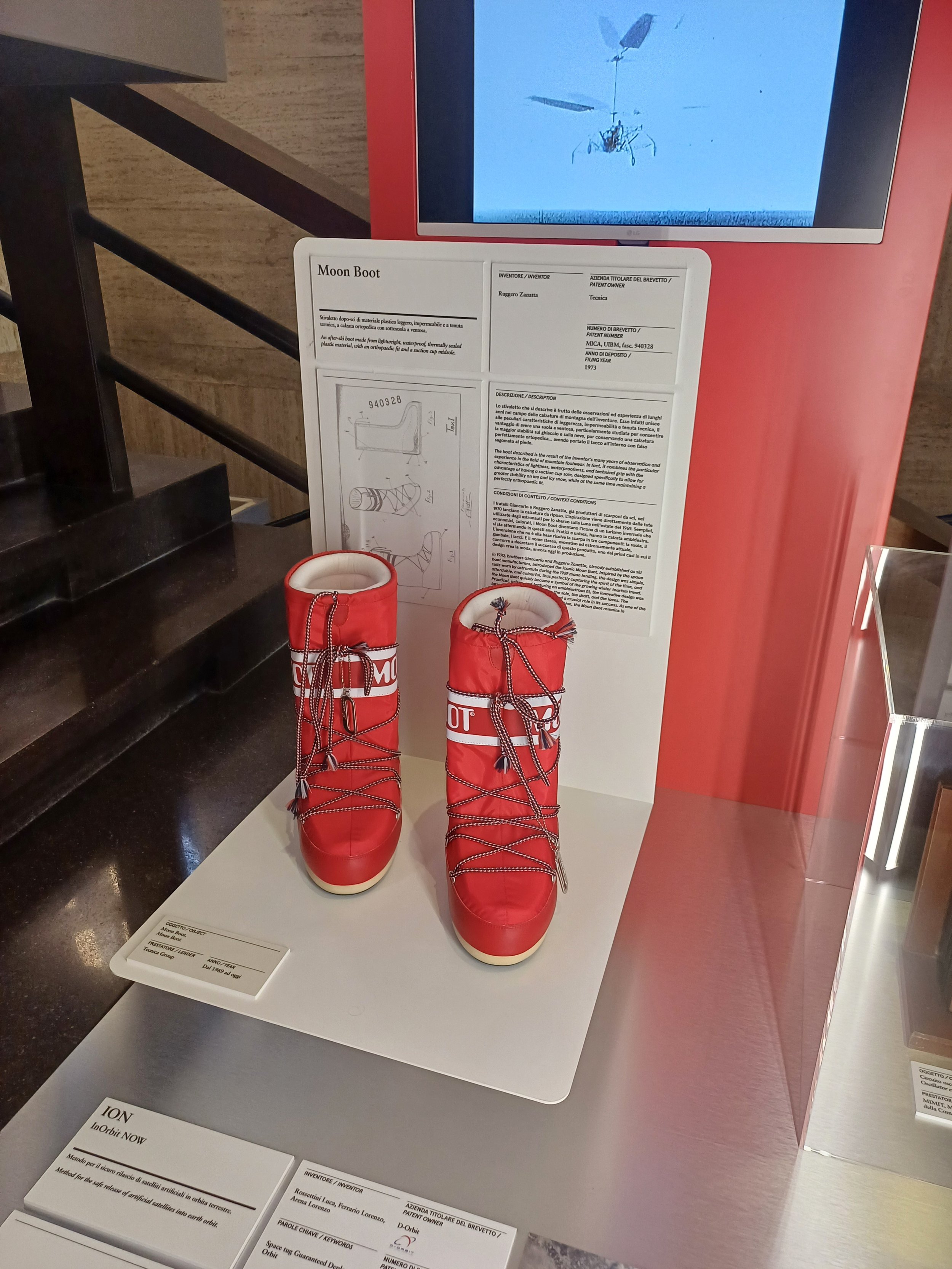In un mondo sempre più dinamico e competitivo, le aziende devono sapersi distinguere con unicità di prodotto e capacità di adattamento. Creare un articolo che passi alla storia come “iconico” non è solo un modo per consolidare il proprio marchio, ma anche una strada verso innovazione, sostenibilità e diversificazione.
È il caso di Pennelli Cinghiale: azienda di successo da 80 anni che nasce dalla combinazione di tradizione e visione futura, valori che ogni impresa dovrebbe abbracciare per prosperare nel tempo.
Prodotto simbolo come fondamento del marchio
Come dice l’aggettivo stesso, “iconico” non è semplicemente un oggetto di consumo, ma un simbolo che incarna valori, tradizione e identità di un marchio. Esso è riconoscibile, distintivo e capace di evocare emozioni nel consumatore, creando un legame con l’azienda che supera la pura funzionalità del prodotto stesso.
Logo da Wikipedia
L’esempio di cui parliamo qui è quello di Pennelli Cinghiale, azienda italiana che ha trasformato un semplice utensile in un emblema di qualità e tradizione con un successo che dura tuttora. La scelta di questo nome, che reca in sé una forte suggestione, è dovuta nel 1945 al fondatore Alfredo Boldrini che lo registrò come marchio, ponendo le basi per la costruzione di un percorso capace di connotare i prodotti e l’azienda negli anni. Il cinghiale, simbolo di forza e robustezza, rappresenta infatti non solo l’articolo, ma anche l’azienda stessa, conferendole un’identità unica e riconoscibile.
Il prodotto diventa quindi il cuore pulsante del brand, un riferimento per i clienti e un motore di crescita. Affinché questo processo si mantenga nel tempo, però, è necessario un impegno costante per conservare la qualità del prodotto, per adattarlo alle esigenze di un mercato in continua evoluzione e per affiancarlo con altre proposte.
Innovazione e sostenibilità come spinta alla crescita
Se creare un prodotto simbolo è il primo passo, innovarlo costantemente è essenziale per mantenerne la rilevanza e per la competitività dell’azienda. L’innovazione deve essere intesa come un processo che coinvolge anche i processi produttivi, i modelli di business e l’esperienza del cliente.
Pennelli Cinghiale ha saputo adattarsi ai mutamenti del mercato, diversificando la propria offerta e introducendo, ad esempio, accanto ai pennelli, le vernici ecosostenibili.
Gli investimenti in ricerca e sviluppo e l’automazione dei processi hanno permesso di consolidare e migliorare la qualità dei prodotti e il loro impatto ambientale, rafforzando la fiducia dei consumatori.
Tale approccio dimostra che la sostenibilità non è solo un valore etico, ma una leva strategica per distinguersi e avere successo presso i consumatori.
Le aziende non possono più ignorare la sostenibilità, resa indispensabile dalla crescente consapevolezza ambientale e da normative sempre più severe. Questo implica scelte mirate, come l’uso di energie rinnovabili e materiali riciclati, e soluzioni per ridurre l’impatto ambientale. Sebbene necessario, il passaggio alla sostenibilità è complesso, soprattutto per le PMI, a causa di costi elevati e normative articolate. Tuttavia, investire in un modello sostenibile è fondamentale per mantenere la competitività, attrarre clienti sensibili al tema e rafforzare l’immagine aziendale, garantendo un vantaggio duraturo.
Diversificazione: esplorare con coraggio nuovi mercati e settori
Diversificare il portafoglio di prodotti e servizi è un altro elemento chiave per la resilienza e la crescita aziendale. In un contesto di rapidi cambiamenti e di incertezza, affidarsi a un unico prodotto o settore può rappresentare un rischio significativo. Diversificare vuol dire anche sperimentare nuove collaborazioni e sinergie con altre aziende. Le partnership possono portare a soluzioni innovative e a maggiore efficienza operativa, oltre che a rafforzare la rete di relazioni all’interno del settore. La diversificazione geografica consente poi di gestire gli eventuali rischi legati alle situazioni geopolitiche, oggi più che mai presenti.
Anche in questo caso Pennelli Cinghiale ha saputo trovare la strada, entrando nel settore delle vernici e aprendosi ai mercati esteri, anche fuori dall’Europa.
Investire sul marchio: un asset che può essere strategico
In conclusione, un brand forte non consente solo di vendere prodotti, ma trasmette un’identità, una storia e un valore che vanno oltre il semplice acquisto.
Pennelli Cinghiale, che ha recentemente registrato lo spot pubblicitario degli anni ’80 come marchio multimediale (ossia, in base a una recente normativa europea, composto da una sequenza di immagini e suoni), è un chiaro esempio di questa situazione. Grazie alla scelta di sostenere e promuovere il marchio e di investire nello stesso tempo su prodotti e mercati, l’azienda rappresenta oggi un riferimento nel proprio settore.
Il marchio è quindi un vero e proprio asset strategico, capace di generare valore economico e di differenziare l’azienda dalla concorrenza. Per le PMI, l’investimento sul marchio rappresenta un impegno, spesso una sfida, ma anche un’opportunità per rafforzare la posizione sul mercato e attrarre nuovi clienti.
Andrea Calisti
Business Transformation Expert
BLUPEAK - IL BUSINESS È CULTURA ORGANIZZATIVA